L'illusorio trionfo del Male
Note al «Satanasso» di Federico Frezzi
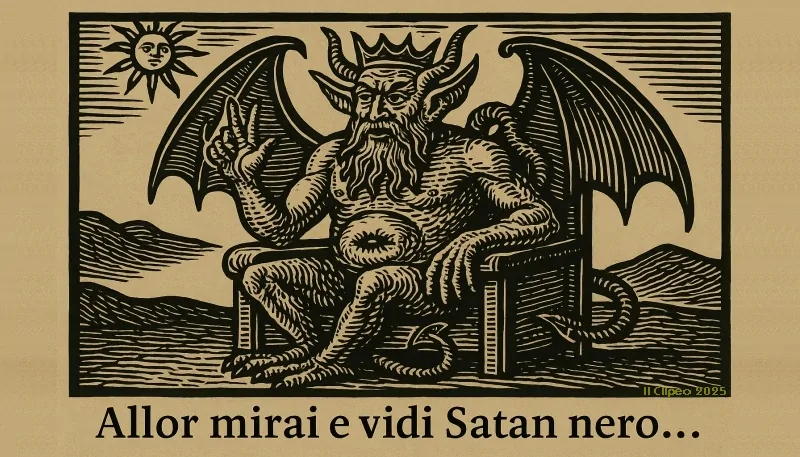
 ederico Frezzi (Foligno, ca. 1350 – Costanza, 1416), domenicano, teologo e poeta, è noto per Il Quadriregio, poema composto di quattro libri, corrispondenti ai quatto regni simbolici visitati dal protagonista: Del regno d'Amore, Del regno di Satanasso, Del regno de' Vizi, Del regno delle Virtù. Con oltre dodicimila versi in terzine dantesche, quest'opera rappresenta una delle più ampie e sistematiche allegorie morali del tardo Medioevo italiano, inserendosi nella scia della Commedia e del Fiore di virtù, ma con una voce autonoma, visionaria e teologicamente stratificata. ✦
ederico Frezzi (Foligno, ca. 1350 – Costanza, 1416), domenicano, teologo e poeta, è noto per Il Quadriregio, poema composto di quattro libri, corrispondenti ai quatto regni simbolici visitati dal protagonista: Del regno d'Amore, Del regno di Satanasso, Del regno de' Vizi, Del regno delle Virtù. Con oltre dodicimila versi in terzine dantesche, quest'opera rappresenta una delle più ampie e sistematiche allegorie morali del tardo Medioevo italiano, inserendosi nella scia della Commedia e del Fiore di virtù, ma con una voce autonoma, visionaria e teologicamente stratificata. ✦
I brani che seguono, adeguatamente parafrasati e commentati, sono tratti dal capitolo XIX del secondo libro del poema, e si configurano come un esercizio allegorico di straordinaria compattezza, impiegando strumenti della tradizione escatologica medievale e rielaborando suggestioni bibliche, dantesche e scolastiche.
Come già segnalato da Vittore Branca e Cesare Segre, la produzione didascalico-morale di area centro-italica tra Trecento e Quattrocento è segnata da una tensione tra ornatus retorico e funzione edificante: il testo di Frezzi si inserisce perfettamente in questo quadro, proponendo una rappresentazione del male che fonde visione, simbolismo morale e parodia epica.
Struttura e progressione drammatica
Il componimento si apre con un topos ascensionale ambiguo: l'io lirico sale attraverso una grotta verso la cima di un monte – simbolo consueto dell'ascesi – ma al vertice non trova Dio, bensì Satana in trono.
La costruzione narrativa mima una visio allegorica, con elementi che richiamano la Commedia di Dante (Inferno I; Inferno XXXIV) ma in un tono più didattico e meno teologicamente compiuto.
L'intera struttura può essere riassunta in quattro momenti fondamentali:
- L'apparenza gloriosa di Satana: figura luminosa, incoronata, osannata da folle e circondata da armonia mondana.
- L'intervento della Sapienza (Minerva/Palla): offerta dello scudo-cristallo e invito alla contemplazione dell'essenza.
- La rivelazione dell'orrore: descrizione anatomico-bestiale del vero Satana, in un crescendo di deformazione simbolica.
- Il crollo finale: tentativo di ascesa, caduta a capofitto, bestemmia e rientro sconfitto.
La dinamica mima un percorso di disinganno morale, dove il male si rivela nella sua natura più autentica: menzogna, superbia, perversione.
Satana tra estetica e morale
Nella prima parte, Frezzi riprende un topos patristico e biblico ben noto:
"Satanas enim transfigurat se in angelum lucis" (2 Cor. 11,14).
Il Satana descritto come bello, regale, ammirato, è specchio della seduzione del male, la cui potenza non si esprime nell'orrore immediato, ma nella capacità di indurre a credere nel falso bene. Le tre corone, le sei ali, le proporzioni armoniche, i giardini, le danze: tutto richiama un universo che mima il Paradiso, ma ne è caricatura.
Il passaggio alla "vera visione" è affidato non alla grazia divina (come in Dante), bensì alla Sapienza filosofica: Minerva, dea della ragione e della scienza. Il cristallo dello scudo rappresenta la capacità gnoseologica di discernere l'essere dal sembrare – categoria profondamente tomista.
Simbologia del corpo e retorica della caduta
L'orrore si manifesta in forma anatomica: Satana è un corpo mostruoso composto da serpenti, draghi, artigli, scorpioni.
Come osserva Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, la rappresentazione fisica del male è necessaria per "mostrare al volgo con li sensi ciò che col lume della ragione non intenderebbero".
La caduta ha un tono grottescamente teatrale: Satana tenta di elevarsi "sopra gli astri", vuole conquistare "l'uno e l'altro polo" (nord e sud, ma anche spirituale e materiale), ma cade "a trabocconi e col capo di sotto".
Il gesto delle "fiche" a Dio è un atto di disperazione infantile: residuo di una superbia incapace di trasformarsi in reale potere. La punizione non è tanto fisica quanto ontologica: egli è ridotto a mimo dell'autorità, inchiodato al proprio fallimento.
✦ Il testo del poema, consistente in quattro Libri e 74 capitoli complessivi, qui di seguito riportato limitatamente ai versi 1-99 del capitolo XIX del Libro secondo, e corredato da parafrasi, commento e note nostri, è tratto da: Frezzi, Federico. Il Quadriregio. A cura di Enrico Filippini. Laterza, 1914.
(Il Quadriregio, Libro secondo, cap. XIX, vv. 1-99)
Come l'autore trova Satan trionfante nel suo reame
(vv. 1-27)
Dentro la porta su per una grotta
fu la via nostra insin in co' del monte
con poca luce, come quando annotta.
Quando fui su e ch'io alzai la fronte,
vidi Satáno star vittorioso,
ove risponde il deritto orizzonte.
Credea vedere un mostro dispettoso,
credea vedere un guasto e tristo regno,
e vidil triunfante e glorioso.
Egli era grande, bello e sí benegno,
avea l'aspetto di tanta maièsta,
che d'ogni riverenza parea degno.
E tre belle corone avea in testa:
lieta la faccia e ridenti le ciglia,
e con lo scettro in man di gran podesta.
E, benché alto fusse ben tre miglia,
le sue fattezze rispondean sí equali
e sí a misura, ch'era maraviglia.
Dietro alle spalle sue avea sei ali,
di penne sí adorne e sí lucenti,
che Cupido e Cilleno non l'han tali.
Ed avea intorno a sé di molte genti
che facean festa, e questi tutti quanti
al suo comando presti ed obbedienti.
Ma i primi e principal eran giganti
con orgogliosi fasti e con gran corti,
con presti servidor, che avean innanti.
✏️ Parafrasi
Percorremmo, salendo per una grotta, un sentiero che conduceva fino alla cima del monte, dove la luce era scarsa, come al calare del giorno.
Quando raggiunsi la vetta e alzai lo sguardo, vidi Satana in atteggiamento trionfante, là dove il cielo tocca l'orizzonte.
Mi aspettavo di vedere un mostro ripugnante, pensavo di trovare un regno in rovina e pieno di dolore, e invece apparve glorioso e vittorioso.
Era grande, bello, dall'aria benevola, e mostrava una tale maestà nell'aspetto da sembrare degno di ogni riverenza.
Portava tre belle corone sul capo, aveva il volto sereno e lo sguardo ridente, e uno scettro regale che simboleggiava grande potere.
Pur essendo alto almeno tre miglia, le sue proporzioni erano perfette, armoniose, tanto da destare meraviglia.
Alle sue spalle spuntavano sei ali, adornate di piume splendenti e luminose, più belle di quelle di Cupìdo e di Mercurio.
Attorno a lui c'erano molte genti, che lo osannavano in festa, tutte pronte e obbedienti al suo comando.
I primi e più eminenti tra queste erano giganti, carichi d'orgoglio e circondati da fasti e splendide corti, seguiti da servi rapidi e zelanti, sempre pronti a precederne i bisogni e i movimenti.
📚 Commento
1. Struttura della visione
L'ingresso in scena è dantesco: l'ascesa attraverso una grotta e una porta rimanda all'ingresso nell'aldilà (Inferno III). Tuttavia qui si sale – in un rovesciamento topografico che contribuisce a creare ambiguità: si pensa di salire verso la luce e il bene… ma si arriva al trionfo del male.
2. Satana come figura maestosa
La descrizione iniziale è volutamente positiva, sontuosa, seducente. Satana appare come un re celeste: tre corone, scettro, viso sereno, proporzioni perfette, sei ali splendenti. La sua apparenza inganna. È il trionfo della superbia angelica, che si manifesta con bellezza, ordine e armonia apparente. L'intero scenario è un capolavoro di illusione allegorica, dove il male si traveste da bene, l'orrore da bellezza, la menzogna da maestà.
L'ambiente è quello di una corte sontuosa, popolata da creature perfettamente allineate e adoranti. L'aggettivo "benegno" e la triade delle corone sono ironici: alludono alla Trinità perversa del potere infernale.
🔍 Note testuali
– "gran podesta": la regalità di Satana è solo apparente, ma qui è descritta come reale. L'autore gioca sull'equivoco visivo per introdurre il tema dell'inganno.
– "tre miglia": l'altezza iperbolica sottolinea la sproporzione tra la grandezza materiale e il vuoto spirituale.
– "che Cupido e Cilleno non han tali": Cilleno è Mercurio, messaggero degli dèi. Cupido rappresenta l'amore istintuale. Satana li supera entrambi: la sua seduzione è persino più potente.
3. Il coro delle genti
Attorno a Satana stanno folle adoranti, simbolo degli uomini traviati o dei demoni a lui sottomessi. La loro obbedienza immediata mostra il carisma illusorio del potere malvagio, che attira e domina senza sforzo apparente.
I giganti, citati nell'ultima terzina, sono simbolo di potere ribelle e arrogante: secondo la tradizione biblica (Genesi 6,4) e dantesca (Inferno XXXI), sono figure che incarnano la superbia originaria, proprio come Satana stesso.
La loro presenza sancisce la parodia grottesca dell'ordine celeste: anche l'Inferno ha i suoi "nobili", le sue gerarchie, la sua coreografia… ma tutto è falso, corrotto, effimero.
(vv. 28-48)
Alla guardia di questi arditi e forti
erano quei che son viri e cavalli,
con li lor capitani saggi e accorti.
Su per li prati ancor vermigli e gialli
andavan donzellette e belle dame
con melodie soavi e dolci balli.
Quand'io stava a mirar tanto reame
e vedea il gran Satán nell'alto seggio
sí bello ed obbedito pur ch'e' chiame,
io dissi: – O Palla, or che è quel ch'io veggio?
Già calo ad adorarlo li ginocchi:
tanto egli è bello, e grande il suo collegio. –
Ed ella a me: – O figlio mio, se adocchi
per mezzo del cristallo del mio scudo
– allor mel diede ed io mel posi agli occhi, –
tu vederai il vero aperto e nudo,
e non ti curerai dell'apparenza,
alla qual mira l'ignorante e rudo.
Ché chi è saggio risguarda all'essenza,
ché su in quella sta fundato il vero,
e non si muta ed ha ferma scienza. –
✏️ Parafrasi
A protezione di quegli arditi e forti seguaci (le genti osannanti) c'erano quei famosi esseri che sono metà uomini e metà cavalli (i centauri), guidati da capitani saggi e prudenti.
Nei prati, ancora variopinti di rosso e giallo, si muovevano giovani fanciulle e nobili dame, che danzavano con grazia e cantavano dolcemente.
Mentre io osservavo con meraviglia questo grande regno e contemplavo Satana, assiso in alto sul suo trono, così bello e subito obbedito appena parlasse, dissi: – O Palla (Minerva), che cos'è ciò che vedo? Sto quasi per inginocchiarmi ad adorarlo, tanto mi appare bello e maestoso insieme al suo seguito.
E lei mi rispose: – Figlio mio, se osservi attraverso il cristallo del mio scudo (lei me lo porse, ed io lo accostai agli occhi), vedrai la verità chiara e nuda, e non ti lascerai più ingannare dalle apparenze, che solo gli ignoranti e gli stolti prendono per vere; perché chi è saggio guarda all'essenza profonda delle cose, perché in essa risiede la verità, che non cambia e ha fondamento sicuro nella scienza.
📚 Commento
1. Il mondo di Satana come corte mondana
L'autore continua a descrivere il dominio infernale con toni sorprendentemente idilliaci. Il paesaggio è fiorito, popolato da donne danzanti, musica soave, centauri – creature mitiche qui presentate come guardie d'onore. È la seduzione del male che si veste da bellezza: una corte regale, artistica, armoniosa.
🔍 Note testuali
– "viri e cavalli": sono i centauri, simbolo di potenza selvaggia, ma qui resi obbedienti.
– "vermigli e gialli": i colori dell'inganno: fuoco e oro, passione e illusione.
2. La rivelazione attraverso Palla (Minerva)
Il poeta è quasi tentato di inginocchiarsi. E qui interviene la Sapienza (Minerva, chiamata familiarmente "Palla"), per salvarlo dall'inganno. L'atto salvifico è l'offerta dello scudo di cristallo: uno strumento simbolico di visione vera, che permette di vedere "il vero aperto e nudo" – senza i veli dell'illusione.
La contrapposizione è fortissima:
- l'apparenza: l'oggetto della vista fisica;
- l'essenza: l'oggetto della mente, della sapienza interiore.
Minerva incarna la Filosofia, la capacità razionale di distinguere l'essere dal sembrare. È la guida che, come Virgilio per Dante, impedisce all'anima di cedere all'idolo.
3. Temi fondamentali
- La verità come rivelazione spirituale, accessibile solo a chi sa "guardare con l'intelletto".
- Il male come maschera del bene, splendidamente travestito, e quindi tanto più pericoloso.
- L'ignoranza come colpa: "chi è saggio risguarda all'essenza" è un verso che potrebbe stare in Boezio o Tommaso.
(vv. 49-66)
Allor mirai e vidi Satan nero
cogli occhi accesi piú che mai carbone
e non benigno, ma crudele e fèro.
E vidi quelle sue belle corone,
che prima mi parean di tanta stima,
ch'ognuna s'era fatta un fier dragone.
E li capelli biondi, ch'avea prima,
s'eran fatti serpenti, ed ognun grosso
e lungo insino al petto su da cima.
E cosí gli altri peli, ch'avea indosso;
ma quelli della barba e quei del ciglio,
mordendo, el trasforavan sin all'osso.
Le braccia grandi e l'ugne coll'artiglio
avea maggior che nulla torre paia;
e le man fure e preste a dar di piglio;
e di scorpion la coda e la ventraia;
nell'ano e presso al membro che l'uom cela
di ceraste n'avea mille migliaia.
✏️ Parafrasi
Allora guardai meglio e vidi che Satana era nero, con gli occhi accesi come carboni ardenti, e non più sereno e benigno, ma crudele e feroce.
Quelle belle corone che all'inizio mi erano sembrate così nobili, ora erano diventate ciascuna un feroce dragone.
I capelli biondi che portava prima
si erano mutati in serpenti, ognuno grosso
e lungo fino al petto, dalla cima del capo.
Anche gli altri peli del corpo si erano tramutati, e quelli della barba e delle sopracciglia si erano trasformati in serpenti che mordevano fino all'osso.
Le sue braccia erano enormi, e le unghie simili ad artigli più grandi di qualsiasi torre immaginabile, e le sue mani erano ladre, rapide nell'afferrare.
Aveva una coda di scorpione e un ventre simile, e nella zona dell'ano e vicino ai genitali aveva migliaia di serpenti velenosi (ceraste).
📚 Commento
1. Il crollo dell'inganno
Grazie alla "lente della verità" (lo scudo di Palla), il poeta assiste al rovesciamento completo dell'apparenza. L'angelo splendente si trasfigura in una creatura mostruosa e ripugnante, secondo la tradizione iconografica dell'Inferno.
Il contrasto è violentissimo e deliberatamente scioccante. La visione non è solo grottesca, ma moralmente necessaria: mostra il volto vero del peccato, sotto la sua veste seducente.
🔍 "Satan nero / cogli occhi accesi": nero, simbolo del male e della menzogna; gli occhi ardenti sono la brama, il desiderio distruttivo.
2. Simbolismo dei draghi e dei serpenti
- Le corone → ora sono draghi: il potere mondano è degenerato in violenza, il simbolo regale in simbolo infernale.
- I capelli → serpenti: evidente riferimento meduseo, ma anche a Lucifero come padre della menzogna, come Giona in bocca al Leviatano.
🔍 "Ceraste": velenosissimi serpenti dell'antichità, associati al demonio. Collocati nei genitali e nelle parti basse, simbolizzano la lussuria e la perversione, le passioni inferiori che l'uomo non domina.
3. Bestiario simbolico
- Artigli giganti → rapacità.
- Coda e ventre di scorpione → ferocia velenosa e vendicativa.
- Unghie grandi come torri → disumanizzazione del potere.
Questa trasformazione si lega direttamente a un tema centrale della tradizione medievale: il male è inganno e deformazione. Non è mai solo ciò che appare: è menzogna ontologica.
(vv. 67-87)
Argo non ebbe mai sí grande vela,
né altra nave, come l'ali sue,
né mai tessuta fu sí grande tela;
ma non atte a volar troppo alla 'nsue,
se non come l'uccello infermo e stanco,
che tenta volar alto e cade ingiue.
Serpentin era il piè deritto e 'l manco;
e diece draghi maggior che balena
faceano a lui il seggio e 'l tristo banco.
E questo a Satanasso è maggior pena:
che sempre insú volar s'ingegna e bada,
e la gravezza sua a terra el mena.
E Dio permette ben che alla 'nsú vada;
ché, quanto piú volando in alto monta,
tanto convien che piú da alto cada.
Io 'l vidi in piè levar con faccia pronta
dall'alto seggio suo, e con orgoglio
udii ch'e' disse: – O Dio, alla tua onta
sopra gli astri del cielo or salir voglio:
io intendo prender l'uno e l'altro polo
al tuo dispetto, ed ora il ciel ti toglio. –
✏️ Parafrasi
La nave Argo (la mitica nave degli Argonauti) non ebbe mai vela tanto grande come le sue ali, né fu mai tessuta tela più estesa.
Ma quelle ali non erano davvero capaci di volare, se non come un uccello malato e stanco, che tenta di levarsi in alto ma cade rovinosamente.
Al posto dei piedi (destro e sinistro) aveva serpenti; e dieci draghi, più grandi di balene, gli facevano da trono e da sedile maledetto.
E questa è la più grande pena di Satana: egli tenta sempre di volare verso l'alto, ma il suo stesso peso lo trascina in basso.
Dio però lo lascia tentare di salire, perché quanto più si innalza con superbia, tanto più rovinosa sarà la sua caduta.
Io lo vidi allora alzarsi in piedi, con volto audace, dal suo trono, e con grande orgoglio lo udii dire: – O Dio, per farti oltraggio, salirò sopra gli astri del cielo; voglio conquistare entrambi i poli (nord e sud), a tuo dispetto, e strapparTi il Cielo.
📚 Commento
1. La parodia della grandezza
Le ali enormi di Satana, più grandi delle vele di Argo, sono un simulacro di potenza: sembrano fatte per volare, ma non lo sono.
L'immagine dell'uccello stanco e malato è tragica e umoristica insieme: il diavolo che voleva essere come Dio, ridotto a un animale che non sa librarsi.
L'autore gioca qui con ironia potente: la sproporzione fra il corpo e la possibilità reale è una condanna.
2. Il trono mostruoso
Satana siede su draghi giganteschi, più grandi di balene: il suo potere non è fatto di troni d'oro o gloria, ma di mostri e oscurità.
Ogni parte del suo corpo è abitata da serpenti e simboli di menzogna. Il male genera solo deformità.
🔍 "il tristo banco": il seggio del male, come trono di lucida disperazione.
3. La caduta come legge divina
"quanto piú volando in alto monta,
tanto convien che piú da alto cada".
Qui Frezzi enuncia il principio della hybris punita: la superbia angelica viene lasciata crescere da Dio perché si autodistrugga.
Questa è la pedagogia della rovina: il male è lasciato esistere affinché si manifesti come falso.
4. Il grido blasfemo
Satana osa dire:
"sopra gli astri del cielo or salir voglio:
io intendo prender l'uno e l'altro polo".
Vuole dominare l'universo fisico, Nord e Sud, e "togliere il cielo a Dio" – suprema bestemmia, già contenuta in Isaia 14,12-14 ("Ascenderò nei cieli… sarò simile all'Altissimo").
Qui il diavolo non è solo figura morale: è nemico cosmico, l'antagonista di Dio.
(vv. 88-99)
Così dicendo, alla 'nsú prese il volo:
ben diece miglia insú s'era condotto,
quando 'l vidi calar al terren sòlo
a trabocconi e col capo di sotto,
e come un monte fece gran ruina.
E, poiché 'n terra fu col capo rotto,
la faccia verso il ciel volse supina,
e fe' le fiche a Dio 'l superbo vermo
e biastimò la Maiestá divina.
Poi si levò sí come fusse infermo,
e verso il suo gran seggio mosse il passo
con mormorio e dispettoso sermo.
✏️ Parafrasi
Così parlando, Satana tentò di volare verso l'alto; riuscì a salire anche dieci miglia nel cielo, ma poi lo vidi precipitare da solo a terra capovolto, rovinando giù di testa, e il suo schianto fu fragoroso come quello di un monte.
Quando toccò terra con il cranio fracassato, volse il volto supino verso il cielo e fece le fiche a Dio (gesto di scherno), quel verme superbo, e bestemmiò la maestà divina.
Poi si rialzò, barcollante come un malato, e si incamminò verso il suo trono oscuro borbottando e lamentandosi con rabbia.
📚 Commento
1. La caduta epica e comica
La discesa di Satana è rovinosa, grottesca, persino fisicamente ridicola: – "a trabocconi e col capo di sotto".
È il trionfo della giustizia divina, che non ha bisogno di fulmini: basta la legge della superbia che precipita nel nulla.
– "come un monte fece gran ruina":
richiamo dantesco (Inferno XII) ma con un'esplosione quasi fumettistica.
Il tono è teatrale e sarcastico insieme.
2. Il gesto delle "fiche"
– "fe' le fiche a Dio":
(anche questa, menzione dantesca, Inferno XXV,2) è il gesto più basso e ingiurioso del Medioevo, antenato dell'odierno "gesto dell'ombrello": si faceva infilando il pollice fra l'indice e il medio chiusi a pugno.
L'autore lo usa per abbassare Satana all'estremo del ridicolo: non solo sconfitto, ma infantile, rabbioso, patetico.
3. Il rientro solitario
Dopo la caduta e la bestemmia, Satana torna al suo seggio, non più glorioso ma triste, sconfitto, camminando come un infermo, borbottando da vecchio folle e offeso.
È l'immagine finale del male impotente: superbo e vuoto, incapace di dominare, in grado solo di offendere.
Tutto si conclude in un rovesciamento integrale: la gloria iniziale è solo una maschera, la verità sta nella caduta e nel ridicolo del male smascherato.
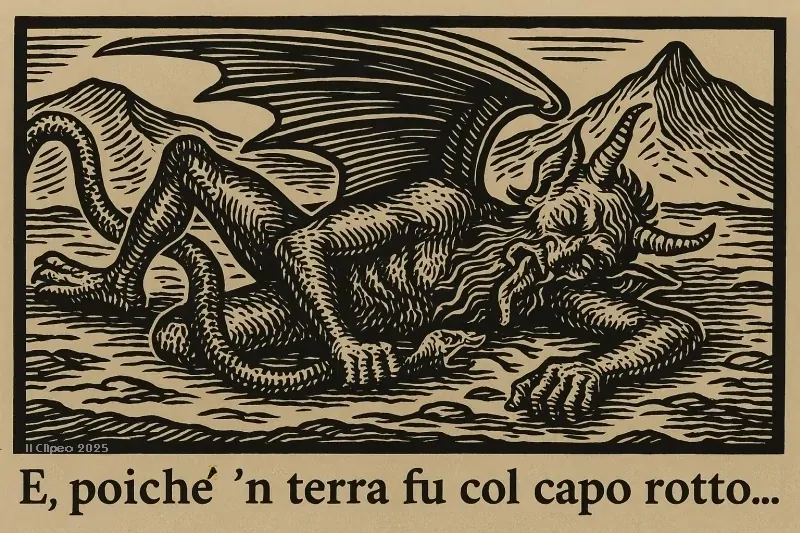
Il Quadriregio di Federico Frezzi si rivela un testo profondamente morale e visivo, un esercizio sapiente di allegoria morale e satira escatologica che coniuga:
- la retorica esemplare dell'età didattico-allegorica;
- l'immaginazione visionaria debitrice della Commedia;
- un tono satirico-simbolico che anticipa tratti della futura letteratura infernale (fino a Milton e Blake, per certi versi formali).
Nonostante il suo status di "minore", il poema è un prezioso documento culturale della transizione tra il Trecento moraleggiante e la crisi quattrocentesca dell'immaginario. L'autore, più che maestro teologico, è testimone di una tensione: quella tra splendore apparente e verità interiore. E in ciò, si dimostra perfettamente medievale.
Bibliografia essenziale
- Frezzi, Federico. Il Quadriregio. A cura di Enrico Filippini. Laterza, 1914.
- Laureti, Elena e Piccini, Daniele. Federico Frezzi e il "Quadriregio" nel sesto centenario della sua morte (1416-2016). Longo, 2020.
- Boccaccio, Giovanni. Trattatello in Laude di Dante. A cura di Pier Giorgio Ricci. Tallone, 1969.
- Croce, Benedetto. Poesia popolare e poesia d'arte: studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento. Laterza, 1933.